 Gruppo di manifestanti contro l’aborto, Finnis, 1975.
Gruppo di manifestanti contro l’aborto, Finnis, 1975.
In questo saggio pubblicato nel 2006, il ricercatore canadese Stuart J. Murray sostiene che l’atto omicida-suicida dell’attentatore equivale a una precisa risposta: è una forma di resistenza al potere biopolitico, e pertanto è possibile parlare, rovesciando i termini, di tanatopolitica.
Attraverso il suo gesto distruttivo, l’attentatore annienta sia la vita degli altri che la sua, sottraendo in questo modo se stesso al controllo biopolitico che scaturirebbe, per esempio, nel caso di una sua possibile imputazione criminale e penale, o nella sottomissione a un trattamento medico.
Seguendo il ragionamento di Murray, l’atto terroristico non rappresenta un’azione di per sé pienamente negativa, in quanto realizza qualcosa, e ciò che produce l’attacco è appunto la morte.
Attraverso questo saggio, il ricercatore propone dunque una «modesta trattazione a proposito dell’attentatore suicida, la cui morte – così come quella delle sue vittime – richiede un discorso aggiornato sulla morte nel nostro tempo. […] Questo articolo tratterà della morte, di molte morti – morti ambivalenti – non nel vano tentativo di dar loro un nome o di enumerarle, ma per provare a iniziare a capire come la morte caratterizzi la nostra vita politica odierna».11Tutti i riferimenti testuali, laddove non indicato, si riferiscono alla presente traduzione riportata nell’articolo.
Andando contro tendenza rispetto alle consuete analisi effettuate intorno a tale fenomeno, solitamente impegnate sulla ricerca e sull’analisi delle cause e delle ragioni dell’atto terroristico omicida-suicida, Murray sposta la riflessione su un piano più esistenziale, chiamando in causa l’essere umano stesso «piuttosto che imporre una qualche visione dominante di causalità e di ragione».
La sua opera, come da lui stesso dichiarato, non si presenta come un saggio esaustivo e risolutivo rispetto alle questioni sollevate, ciononostante si configura come un punto di inizio, un modo per avviare nuove riflessioni e studi su tale inconsueta lettura dell’atto omicida-suicida, in grado di mutare il volto dell’odierna vita politica.
Murray muove la propria riflessione su un doppio binario, utilizzando le ricerche condotte da Michel Foucault e Achille Mbembe. Partendo da quello che definisce come «il paradigma politico dominante nelle odierne democrazie occidentali», ovvero la biopolitica – concetto introdotto per la prima volta da Foucault –, Murray approda agli studi postcoloniali di Mbembe.
In età premoderna il discorso intorno alla morte era ancora legato al diritto esercitato dal potere sovrano di scegliere se togliere o lasciare la vita ai propri sudditi: come suggerisce Murray, l’epoca moderna inverte invece l’ordine dell’assunto premoderno (“prendere la vita o lasciare vivere”), in «far vivere o lasciar morire». In questo modo la vita diviene pertanto la categoria entro cui è possibile comprendere la morte. Ed è proprio attraverso questa categoria che il potere sovrano moderno esercita il proprio controllo, regolamentando inoltre molti aspetti della vita dei suoi cittadini.
All’interno di tale scenario, la vita innalzata a valore supremo è qualcosa che va a tutti i costi preservato e riconosciuto, mentre la morte diviene quasi un argomento tabù, una parola indicibile e scomoda: «La morte non capita mai a me, non capita mai a me stesso».
La morte, che dev’essere tenuta lontana, arriva sino al centro degli stati secolari, terrorizzando i suoi cittadini. Attraverso gli attacchi dei terroristi, la morte può capitare “anche a me” e, come sostiene Roberto Calasso nel suo ultimo libro, L’innominabile attuale, la potenza che muove il nuovo terrorismo è il caso: «La potenza che muove il terrorismo e lo rende assillante non è religiosa, né politica, né economica, né rivendicativa. È il caso. Il terrorismo è ciò che rende visibile il potere ancora inscalfito che regge il funzionamento del tutto e ne svela il fondamento. Al tempo stesso è una modalità eloquente con cui si manifesta nella società l’immensa difesa di ciò che la circonda e l’ignora. Occorreva che la società giungesse a sentirsi autosufficiente e sovrana perché il caso si presentasse come suo principale antagonista e persecutore».22R. Calasso, L’innominabile attuale, Adelphi, Milano 2017, p. 16.
E prosegue: «Il terrore secolare vuole innanzitutto uscire dalla coazione sacrificale. Passare al puro assassinio. Il risultato dell’operazione deve sembrare totalmente fortuito e disperdersi nei luoghi anonimi. […] E cosa fa più paura: l’uccisione significante o l’uccisione casuale? Risposta: l’uccisione casuale».33Ibid., p. 16.
Ritornando a Murray, un discorso così configurato intorno alla sacralità della vita spiana la strada al regno dei fini: è infatti tramite questo pensiero che qualsiasi azione è permessa in nome della vita.: «Come dimenticare la farsa di George W. Bush, il quasi santificato capo di Stato, che – prodigandosi per “salvare” la vita di Terri Schiavo – ha detto: “è sempre saggio sbagliare a favore della vita”, mentre in veste di governatore del Texas era famoso per firmare gli ordini di esecuzione e per rifiutarsi di concedere anche la minima amnistia a chiunque si trovasse nel braccio della morte. Ipocrisie simili sono di per sé difese in nome della vita».
I ragionamenti di Mbembe, a cui si aggaccia Murray, ribaltano le letture standardizzate sulla dominazione occidentale, ossia tutte quelle categorie binarie, in cui si trovano contrapposti i concetti di: resistenza/passività, autonomia/assoggettamento, Stato/società civile, egemonia/contro-egemonia, totalizzazione /de-totalizzazione. E proprio attraverso gli studi di Mbembe Murray intende avviare una critica al moderno umanesimo liberale: «Secondo le parole di Mbembe, si tratta di “critica dell’eurocentrismo: una sorta di soggetto individuale che – pur cercando di passare per l’universale tout court – finisce sempre per legittimare la violenza della sua irrazionalità in nome della ragione».
Mbembe si serve delle riflessioni legate al razzismo, alla modernità, al colonialismo e alla sovranità, elaborate parzialmente da Foucault, per avviare una nuova lettura e analisi, giungendo a rovesciare il concetto foulcaultiano di biopolitica nel suo opposto, necropolitica, concetto tramite cui il filosofo intende innanzitutto rappresentare il rapporto di potere instaurato dalla sovranità moderna occidentale ai danni delle popolazioni coloniali.44Necropolitica è il titolo di un saggio di Mbembe pubblicato in Italia nel 2016 per Ombre Corte.
La presente traduzione del saggio di Murray riguarda la prima metà dell’opera, composta in tutto da quattro sezioni (Foucault: la biopolitica e il silenziamento della morte oggi; Introduzione: L’attentatore suicida; Kant sul Suicidio, Kant su un altro modo di immaginare; Conclusione: il linguaggio della vita quotidiana).
Introduzione di Simona Squadrito
«Se uno non è un essere umano, che cos’è uno?».
(Achille Mbembe)«Vai a farti ammazzare e ti promettiamo una vita lunga e felice».
(Michel Foucault)
«Se uno non è un essere umano, che cos’è uno?». Finché uno è, uno è chiaramente un essere umano: l’umanità manifesta di uno è strettamente legata all’esistenza di uno, alla sua vita soggettiva. Forse questo è meno ovvio se l’esistenza e la vita stesse sono rese impronunciabili e impensabili; se l’esistenza e la vita sono private del loro significato saliente. Così, oltre a “che cosa” sia un essere umano, nella domanda di Achille Mbembe riecheggia un’altra domanda, nella ripetizione di “uno”, di uno che è molti. Forse non c’è una migliore definizione iniziale di politica di questa: la natura della relazione tra uno e molti. Che cos’è un essere umano? Oltre alla domanda “cosa”, che potremmo definire una domanda di contenuto, la forma della domanda di Mbembe è anche e soprattutto un modo di interpellare noi, i suoi lettori. Così la sua domanda chiede anche implicitamente “chi”: un quesito che in qualche modo ci riguarda e che richiede una risposta da ciascuno di noi; una domanda che chiama in causa l’essere umano e che ci chiede che cosa significhi essere umano, dal momento che l’identità di questi termini non si può presupporre.
 Marcia contro l’aborto del movimento Pro-Life, 2015.
Marcia contro l’aborto del movimento Pro-Life, 2015.
Ma finché noi stessi siamo messi in questione, lo è anche il nostro accesso alle condizioni normative entro le quali può essere formulata qualsiasi risposta adeguata alla questione umana. La domanda di Mbembe – “chi” e “cosa” – rimane senza risposta e in parte senza possibilità di risposta, perché chiama in causa l’unicità dell’uno: «Se uno non è un essere umano, che cos’è uno?». Chi o cosa è il referente singolare in questione? Sono io l’uno, sono inequivocabilmente io? O è piuttosto un essere umano in generale, astratto e unitario, una sorta di nozione universale di essere umano? E se così fosse, quando rivolge questa domanda a me, lettore, la formulazione di Mbembe solleva la questione della mia stessa umanità, scatenando un’ambivalenza disturbante in seno alla questione stessa della mia vita, proprio lì dove pensavo che fosse più ovvia, proprio nel momento in cui mi consideravo come il suo inequivocabile destinatario. Dovrei rispondere o rimanere in silenzio? E se parlo, come posso essere sicuro di parlare in nome dell’essere umano? Quali sono – sembra chiedere Mbembe – le norme del mio discorso, e le norme dell’essere umano? L’apostrofe della voce sovrana ripresa da Michel Foucault invoca ugualmente una crisi normativa: «Vai a farti ammazzare e ti promettiamo una vita lunga e felice». Qui, in tono ironico, Foucault dipinge lo Stato sovrano come un potere che allo stesso tempo ordina e promette. È ironico perché la promessa contravviene direttamente al comando: a rigor di logica, se vengo ucciso la mia vita sarà tutto fuorché “lunga e felice”. Eppure è possibile intenderlo in un altro senso, per cui l’ordine/promessa non si contraddice. L’ordine/promessa è diretto a un “tu” che – proprio come il destinatario di Mbembe – non è uno; un “tu” la cui unicità è messa radicalmente in gioco, la cui unicità è pronunciata in nome di molti. L’anonimo “noi”, che allo stesso tempo comanda e promette, si rivolge a un altrettanto anonimo “tu”, un “tu” che, se proprio è incluso nel “noi”, lo è solo in modo ambivalente. Ovviamente la vita che ti viene ordinato di sacrificare, l’esistenza che ti si ordina di revocare, non è la stessa vita che ti è promessa. Allora in che modo la mia singola vita – l’unica che ho da dare – può essere messa in relazione con la vita politica collettiva, la vita di una nazione o di una popolazione la cui unità è indiscutibile? L’ambivalenza strategica delle parole di Mbembe e di Foucault richiama la famosa teoria dei due corpi del re.77Cf. E. Kantoriwicz, The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology, Princeton, University Press Princeton 1985.
Il re, il sovrano, non è uno solo, e nonostante la sua morte, la sua vita infinita è una specie di punto d’arrivo retorico e collettivo, raggiunto al prezzo di molti. La vita del potere sovrano è una vita che è vissuta all’ombra della morte – di molte morti, innumerevoli e senza volto, rinnegate e dimenticate. Come nota Foucault, «in termini di rapporto con il sovrano, l’individuo non è, di regola, né morto né vivo».88M. Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the Coll.ge de France, 1975-1976, trans. David Macey, Picador, New York 2003, p. 240.
Questo articolo tratterà della morte, di molte morti – morti ambivalenti – non nel vano tentativo di dar loro un nome o di enumerarle, ma per provare a iniziare a capire come la morte caratterizzi la nostra vita politica odierna. A dire il vero, il fatto che “la morte caratterizzi la vita” ci sembrerà contrario al buon senso, se non folle, perché, come ha affermato Foucault, negli ultimi due secoli non parliamo più di morte in maniera appropriata. Le trattazioni concernenti la morte sono altrettanto dimenticate e rinnegate quanto le stesse innumerevoli e anonime morti. Negli ultimi due secoli – sostiene Foucault – gli argomenti politici si sono concentrati invece sulla vita. La vita ha eclissato la morte. In nome della vita, la “fossa comune” è diventata popolare, rendendo la morte (o le morti) innumerevoli e anonime, oscure e oscurate. In questo contesto, l’ordine del sovrano di “andare a farsi ammazzare” non ha nulla a che fare con una qualche morte (di uno); è pronunciato in nome della vita, della squisita purezza e bellezza della vita promessa, che sia qui sulla terra o in una qualche paradisiaca Nuova Gerusalemme.
La nostra epoca è, quindi, l’epoca della vita, l’epoca di quella che Foucault chiama la “biopolitica” – una politica che è organizzata da e per il controllo e la regolamentazione della vita. La biopolitica è la politica caratterizzata da un discorso sulla vita che riguarda la vita nella misura in cui essa sembra, strategicamente, appartenere alla vita stessa, alla naturale estensione del valore sacro – e quindi indiscutibile – della vita. Foucault riassume il potere della biopolitica così: «Il tentativo, iniziato nel XVIII secolo, di razionalizzare i problemi posti all’esercizio governativo dai fenomeni caratteristici di un gruppo di esseri umani in vita, costituitosi come popolazione: sanità, igiene, tasso di natalità, longevità, razza».99M. Foucault, The Essential Foucault, ed. Paul Rabinow and Nikolas Rose, The New Press, New York 2003, p. 202.
La biopolitica è quindi la razionale, sovrana regolamentazione e controllo della popolazione. Questo rimane il paradigma politico dominante nelle odierne democrazie occidentali, per quanto esso sia sempre più soggetto all’influenza dell’ideologia neoliberale. La vita stessa è regolata, massimizzata e sfruttata attraverso la politica governativa, il capitalismo globale del libero mercato, una giuridicizzazione in costante crescita, la medicalizzazione ecc.; ovvero, la missione morale di un “secolare sacro”. Una tale visione della vita è promossa, di conseguenza, in quanto bene universale. Agisce come una cosmologia virtuale per noi che le siamo assoggettati. E un discorso del genere rende molto comodo, se non necessario, il fatto di rinnegare la morte come qualcosa di quasi immorale e alieno, e di dimenticare che spesso il prezzo della vita è la morte stessa. In nome della vita, la morte è vietata. Che cosa significherebbe, allora, parlare in nome della morte? È possibile un discorso di questo tipo?
 Andy Warhol, Electric Chair, litografia, 1964.
Andy Warhol, Electric Chair, litografia, 1964.
Introduzione: L’attentatore suicida
In questo articolo propongo una modesta trattazione a proposito dell’attentatore suicida, la cui morte – così come quella delle sue vittime – richiede un discorso aggiornato sulla morte nel nostro tempo. Negli ultimi anni sono stati versati fiumi d’inchiostro a proposito della figura dell’attentatore suicida, focalizzandosi spesso sul conflitto israelo-palestinese nello specifico. Mentre questi libri tendono frequentemente a storicizzare il conflitto (o meglio, i conflitti), alcuni di essi si occupano anche di comprendere e di spiegare le cause o la “logica” dell’attentatore suicida. Per esempio, Robert Pape si impegna a trattare proprio questo tipo di “logica” nel suo libro Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. E molti di questi libri ricorrono a un resoconto “dall’interno”: per esempio, Army of Roses di Barbara Victor parla delle donne palestinesi che compiono attentati suicidi, mentre Suicide in Palestine di Nadia Taysir Dabbagh dà voce agli attentatori, così come anche Occupied Voices di Pearlman, My Life Is a Weapon di Christopher Reuter e The Road to Martyrs’ Square di Anne Marie Oliver e Paul F. Steinberg, per non citarne che alcuni.1010Il lettore interessato potrà consultare: Scott Atran, In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion, Oxford University Press, New York 2002; e “Genesis of Suicide Terrorism”, Science 299 (2003): 1534-39; Nadia Taysir Dabbagh, Suicide in Palestine: Narratives of Despair, Olive Branch Press, Northampton, MA 2005; Philip B. Heymann, Terrorism, Freedom, and Security: Winning Without War, MIT Press, Cambridge, MA 2003); Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic, Henry Holt and Company, New York 2004); Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, 3rd ed., University of California Press, Berkeley 2003; Walter Laqueur, ed., Voices of Terror: Manifestos, Writings and Manuals of Al Qaeda, Hamas, and Other Terrorists From Around the World and Throughout the Ages, Reed Press, New York 2004; Anne Marie Oliver e Paul F. Steinberg, The Road to Martyrs’ Square: A Journey into the World of the Suicide Bomber, Oxford University Press, New York 2005; Robert A. Pape, Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, Random House, New York 2005; Wendy Pearlman, Occupied Voices: Stories of Everyday Life From the Second Intifada,Thunder’s Mouth Press/Nation Books New York 2003; Christopher Reuter, My Life Is a Weapon, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2004; Barbara Victor, Army of Roses: Inside the World of Palestinian Women Suicide Bombers, Rodale Press 2003. Per una trattazione più teorica, si veda Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press, Stanford 2003; Iain Boal, T. J. Clark, Joseph Matthew, e Michael Watts (Retort Group), Afflicted Powers: Capital and Spectacle in the New Age of War, Verso, New York 2005; Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, New York 2004; Jacques Derrida, Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides – A Dialogue with Jacques Derrida, in Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida, ed. Giovanna Borradori, University of Chicago Press, Chicago and London 2003, pp. 85-136; e Rogues: Two Essays on Reason, trans. Pascale-Anne Brault and Michael Naas, Stanford University Press, Stanford 2005; Terry Eagleton, Holy Terror, Oxford University Press, Oxford 2005; Diane Enns, Bare Life and the Occupied Body, «Theory & Event», 7, 3, 2004; Foucault, Society Must Be Defended; Achille Mbembe, Necropolitics, trans. Libby Meintjes, «Public Culture» 15, 1, 2003, pp. 11-40; Jacqueline Rose, Deadly Embrace, «London Review of Books», 26, 21, November 4, 2004, http://www.lrb.co.uk/v26/n21/print/rose01_.html, e The Question of Zion, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2005. Ovviamente questa lista non è assolutamente completa.
Tutti sfidano in profondità l’eccessiva semplificazione dei mezzi di comunicazione di massa occidentali nei confronti di tali eventi e delle loro condizioni, offrendo un quadro più complesso – e probabilmente più giusto – delle dimensioni sociali, politiche e storiche del conflitto. Nello sforzo di confutare il discorso mediatizzato e orientalizzante1111E. Said, Orientalism, Vintage, New York 1979.
del “tipico” attentatore alle prese con la ricerca libidinosa di vergini paradisiache, troviamo in questi testi un’intera gamma di temi – dalla trattazione della storia regionale e globale e della politica, ai rilevanti aspetti delle costrizioni materiali, religiose e familiari. Cito qui di seguito lo studio empirico di Scott Atran, le cui conclusioni non sono nuove in questo campo di studi: «I terroristi suicidi rientrano nella comune distribuzione della popolazione in termini di educazione, status socio-economico e tipo di personalità (per esempio, “introverso” contrapposto a “estroverso”). […] In generale, i terroristi suicidi non mostrano alcun attributo sociale disfunzionale (orfani di padre, senza amici o disoccupati), o sintomi suicidi (per esempio, disordini affettivi, abuso di sostanze, tentativi di suicidio ripetuti). […] Non esprimono “disperazione” o un sentimento di “niente da perdere” per mancanza di alternative di vita, coerentemente alla “razionalità economica” (ovvero, se c’è una sola opzione e nessuna alternativa ragionevole, la prendi); ciononostante, la disperazione è spesso l’interpretazione che viene data da e per i mezzi di comunicazione di massa occidentali, in dichiarazioni destinate al pubblico statunitense ed europeo».1212Atran, In Gods We Trust, pp. 134-135.
Un simile ritratto dell’attentatore suicida non è forse la prima cosa che ci viene in mente. Anzi, l’ordinarietà del terrorista può sconvolgere. Ma è proprio questa ordinarietà che i mezzi di comunicazione di massa occidentali devono eliminare, o altrimenti dovrebbero affrontare domande a cui non sarebbe facile rispondere. Le invenzioni dei media sono più confortanti.
Contrariamente ai nuovi media occidentali di successo, quindi, il trattamento riservato alle missioni suicide nei «mezzi di comunicazione arabi enfatizzano sentimenti di speranza e di “tutto da perdere”».1313Ibid., p. 135.
Pape conferma: il suo notevole studio include dati empirici dettagliati relativamente a «ogni attentato suicida avvenuto nel mondo dal 1980 al 2003; 315 attentati in tutto».1414Pape, Dying to Win, p. 3.
Basandosi sul suo studio demografico approfondito, che indaga le cause verosimili dell’attentato suicida, Pape conclude: «Il moderno terrorismo suicida avviene principalmente all’interno di campagne di attacchi suicidi condotte da gruppi organizzati per specifici intenti politici, e che si estendono lungo un considerevole arco di tempo».1515Ibid., p. 20.
In altre parole, sbagliamo a enfatizzare la “psicopatologia” o il “fanatismo religioso” dell’attentatore suicida in sé. Pape minimizza esplicitamente il valore religioso degli attacchi, insistendo sul fatto che la religione «raramente è la causa ultima».1616Ibid., p. 4.
Afferma, invece, che «il terrorismo suicida è quasi sempre una risposta all’occupazione straniera».1717Ibid., p. 22. Nel contesto iracheno, sotto l’occupazione americana, penso che qualsiasi distinzione tra religioso e non religioso sia diventata più difficile da effettuare. Naturalmente i media ufficiali americani preferiscono depoliticizzare questi avvenimenti, assicurandoci che i recenti attacchi suicidi siano stati compiuti dai fondamentalisti islamici.
Questa conclusione sarebbe confermata dai molti attacchi in Iraq a partire dal 2003, e anche ora in Afghanistan; infatti questi attacchi potrebbero essere visti come una resistenza all’occupazione statunitense di questi Paesi.
Con questo non si intende negare che la religione possa rivestire un ruolo complesso nel reclutamento, nell’addestramento e così via; s’intende, invece, che la religione è raramente la “causa ultima”, il fattore motivazionale determinante. In realtà, secondo lo studio di Pape, la maggior parte degli attacchi suicidi nel mondo sono stati compiuti dal Tamil Tigers, un gruppo che è dichiaratamente antireligioso. Anche Jacques Derrida, a proposito dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, ha espresso brevemente il suo punto di vista: «Ogni terrorista al mondo dichiara di star rispondendo in autodifesa a un precedente terrorismo da parte dello Stato, che semplicemente è noto con altri nomi e che si copre con ogni tipo di giustificazione più o meno credibile».1818Derrida, Autoimmunity, p. 103.
La natura di questo tipo di affermazioni concorrenti rende impossibile una mediazione tra di esse, e quindi rende anche impossibile la determinazione, una volta per tutte, delle “cause ultime” o delle “ragioni” dietro il terrorismo suicida.
La trattazione di questo articolo si dirige verso un diverso tipo di discorso. Per quanto possibile, un simile tentativo è forse persino fiducioso, di fronte a una simile manifestazione di disperazione. Mi riferisco non alle “cause” né alle “ragioni” che motivano l’attentatore suicida, ma preferisco ricollegarmi a Mbembe e Foucault e chiamare in questione l’essere umano, piuttosto che imporre una qualche visione dominante di causalità e di ragione. Prendo ispirazione da Mbembe, che pone agli studi postcoloniali la seguente sfida: «Dobbiamo andare oltre le categorie binarie usate nelle interpretazioni standard di dominazione, quali la resistenza contrapposta alla passività, l’autonomia all’assoggettamento, lo Stato alla società civile, l’egemonia alla contro-egemonia, la totalizzazione alla de-totalizzazione».1919Mbembe, On the Postcolony, p. 103.
Ricorro quindi a una discussione sulla morte, che si voglia chiamarla suicidio o sacrificio. Secondo le parole di Mbembe2020A. Mbembe, On the Postcolony: A Brief Response to Critics, «Qui Parle»,15, 2, 2005, p. 18.
, siamo obbligati “a discutere lo status della morte-in-sé o, più esattamente, di una vita della morte o della vita della morte. Attraverso un approccio di questo tipo, possiamo concludere che la morte – la morte nella vita – mette in crisi le categorie binarie convenzionali e apre necessariamente a qualcosa di nuovo, inaugurando un nuovo discorso, una nuova speranza per la nostra esistenza insieme. In che modo, quindi, la morte dell’attentatore suicida in sé può iniziare a cambiare il volto della vita politica odierna? Qual è la forza retorica di questo tipo di morte, con i suoi innumerevoli effetti sociali, politici e culturali?
 Attentato terroristico allo Stade de France, rivendicato dall’ISIS, 2015.
Attentato terroristico allo Stade de France, rivendicato dall’ISIS, 2015.
Sostengo che la tanatopolitica – la politica della morte – è allo stesso tempo una forma di risposta e di resistenza al potere biopolitico e alla concezione occidentale di sovranità razionale a cui la biopolitica è associata. Ma non è solo questo. Mentre la resistenza dell’attentatore suicida si innesca all’interno dei circuiti di potere, questa forma di resistenza si avvicina anche all’assoluto: costui distrugge la condizione stessa di possibilità per la regolamentazione e il controllo biopolitici. Poiché di solito l’attentatore suicida muore, per esempio, nell’esplosione, costui non può essere coinvolto nel meccanismo della giustizia. Mentre l’attentato suicida è distruttivo ed è chiaramente una manifestazione della forza di negazione, io sostengo che dobbiamo invece intendere questo atto come produttivo – cioè che produce qualcosa, che ha degli effetti retorici indipendenti che non sono facilmente comprensibili all’interno di una logica biopolitica. Questi effetti incidono sulla vita quotidiana e si estendono al di là delle zone di guerra; non è possibile comprendere o spiegare il loro valore simbolico secondo i nostri attuali codici e norme morali. Come capiamo questo tipo di morte – l’omicidio-suicidio – quando è esplicitamente compiuto come atto politico, come sommo – e produttivo – atto di rifiuto? Come si “produce”? E come può questo indurci a riconsiderare la nostra stessa fede in quelle nozioni liberali-umaniste del soggetto che sono state alla base della politica e dell’etica così a lungo? Per rispondere a queste domande, ricorro agli effetti dell’attentato suicida e li considero come retorici, come effetti che producono una risposta particolare, una riposta che non può essere colta attraverso la sola ragione biopolitica. La speranza è allo stesso tempo di evitare l’impasse impostaci dal soggetto sovrano dell’umanesimo liberale – lasciatoci in eredità dalla filosofia moderna dell’Illuminismo – e (all’estremo opposto) un nichilismo postmoderno che distrugge l’etica della responsabilità, che è tradizionalmente allineata con l’operato sovrano. Piuttosto che finire in un discorso trito che condanna ciecamente questi atti, riaffermando il sacro valore della vita (biopolitica), sostengo che un discorso sulla morte allo stesso tempo sfiderebbe l’egemonia della ragione biopolitica e aprirebbe a un nuovo modo di concepire il sacro nella vita politica d’oggi. L’argomentazione seguente si articola in quattro parti principali. Innanzitutto inizierò con la trattazione del concetto di biopolitica in Foucault: in particolare, perché un discorso sulla morte costituisce per noi, oggigiorno, una sfida eccezionale. In sostanza, i nostri termini biopolitici sono inadeguati e quindi, in questo senso, la morte dell’attentatore suicida rimane incomprensibile e fortemente problematica. In secondo luogo, mi rivolgo a Kant, che è uno dei primi filosofi occidentali a trattare il tema del suicidio. Mi riferisco a come Kant guarda alla vita e alla morte in rapporto alla sacra dignità umana, o valore [Würde]. Kant accenna a una ragione per la quale l’aspetto “suicida” dell’attentatore risulta così terrificante, e tuttavia le azioni dell’attentatore oscurano con forza la distinzione kantiana tra “suicidio” e “sacrificio”. Sostengo, quindi, che in Kant possiamo ritrovare le origini della biopolitica moderna così come è stata assunta dallo Stato – ma, ancora una volta, si tratta di una logica biopolitica estremamente fragile, che l’attentatore suicida minaccia di arrestare del tutto. In terzo luogo, nella sua opera sull’immaginazione e il sublime, ancora una volta è Kant che ci aiuta a pensare al di là delle strutture logiche della biopolitica e a teorizzare il tipo di rottura rappresentato dalla morte dell’attentatore suicida. Ciò significa forse leggere Kant contro i kantiani, e offre un modello retorico per nuovi modi in cui possiamo iniziare a pensare al di fuori e al di là degli orizzonti della nostra tradizione liberale. In ultima istanza, infine, la mia trattazione prende in considerazione le dimensioni esplicitamente retoriche della morte, così come queste si rapportano ad aspetti più vasti dell’integrità fisica e della comunità corporea. A questo punto la mia lettura si rivolge alla morte negli spazi della vita quotidiana, per quanto possa essere doloroso, con la sincera speranza che insieme potremo iniziare a immaginare nuove possibilità di una vita politica condivisa.
Foucault: la biopolitica e il silenziamento della morte oggi
«Siamo chiamati a realizzare la nostra vocazione di americani. Siamo chiamati a onorare le nostre proprie norme, annunciate il giorno della nostra fondazione nella Dichiarazione d’Indipendenza. Siamo chiamati dalle nostre convinzioni, dalla nostra tradizione e compassione, a costruire una cultura della vita».2121G. W. Bush, President Bush Signs Partial Birth Abortion Ban Act of 2003, The White
(George W. Bush)
La morte è impronunciabile. È messa a tacere dalla retorica austera e pia del nazionalismo: “onore”, “compassione” e la “cultura della vita” in sé. Mentre nel 2003 dichiarava illegale l’aborto con nascita parziale, il presidente George W. Bush affermava ripetutamente che “siamo chiamati a…”. A ogni modo dobbiamo chiederci: chi è questo “noi”? Chi ci chiama? E in nome di chi? In che modo siamo interpellati dalla sovrana dottrina della vita stessa? Al centro di un simile discorso sulla vita, la morte diventa il più intangibile e invisibile dei problemi che potrebbero mai essere posti. Neanche i nostri migliori scienziati, dottori e giuristi sanno dire con certezza che cos’è la morte in quanto concetto o evento, e ancora la morte getta una lunghissima ombra sulla storia della nostra esperienza del ventesimo secolo. Alla maniera di Nietzsche, potremmo dire che la morte pende come un punto di domanda, punteggiando in modo invisibile le vite dei vivi. Al giorno d’oggi le condizioni nelle quali possiamo rispondere, secondo le quali possiamo parlare di morte in maniera appropriata, si sono sempre più ridotte. La morte non capita mai a me, non capita mai a me stesso. La morte arriva come un estraneo nascosto da un velo, travestita da operazioni militari o poliziesche a lungo termine, come atti terroristici trasmessi in televisione, un evento virtuale o come “attacco mirato”. Quando questo avviene vicino a casa, la morte è capita, ancora una volta, non nei suoi propri termini; avviene, invece, in condizioni sanitarie, come una semplice interruzione della vita, il fallimento o il limite delle tecnologie mediche e politiche, il cui compito principale è quello di mantenere in vita i vivi.
 Andy Warhol, Teschio, litografia,1976-77.
Andy Warhol, Teschio, litografia,1976-77.
Foucault ha ricostruito magnificamente lo storico passaggio di discorso da quello che era in passato un discorso sulla morte alla nostra moderna ideologia di vita. Tradizionalmente, in età premoderna, il discorso sulla morte era compreso dal diritto romano sotto la voce di patria potestà – il potere del padre di famiglia, che godeva «del diritto di ‘disporre’ della vita dei suoi figli e dei suoi schiavi».2222M. Foucault, The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction, trans. Robert Hurley, Random House, New York 1978, p. 135.
Tale potere è riassunto nella seguente espressione: “prendere la vita o lasciare vivere”. Ecco, quindi, il diritto del sovrano di revocare la vita dei suoi sudditi o di permettere loro di vivere – un’economia della morte, per così dire. Così, secondo la teoria classica di sovranità, la bilancia del potere è «sempre inclinata a vantaggio della morte»,2323Foucault, Society Must Be Defended, p. 240.
dove la morte costituiva la categoria attraverso cui si concepiva la vita, in maniera quasi automatica. La vita era quell’elemento invisibile ma pervasivo che era sempre già presente, ma che era annunciato solo attraverso la sua privazione – dalla morte, dalla regola della spada – il glaudius dei.
In epoca moderna, invece, si assiste a un ribaltamento dell’ordine, e la bilancia del potere propende per la vita. La “vita”, o bios, è ora la categoria attraverso cui la morte deve essere compresa. La vita non è più considerata come un dato di fatto, ma viene costituita discorsivamente, in relazione al potere politico – una biopolitica che prefigura il moderno Stato sovrano. Oggi, come afferma Foucault, lo Stato sovrano esercita il suo controllo in maniera assolutamente esplicita, per mezzo della vita, attraverso le vite dei vivi. Esso assume la forma definita di regolatore della vita, massimizzandola e prolungandola. Lo Stato moderno interviene in nome di una sedicente autorità morale per influenzare i tassi di nascita e di morte della popolazione, il loro invecchiamento, malattie, igiene, sanità pubblica e welfare; siamo governati da ideologiche leggi di matrimonio, da polizze “pro-vita”, da “iniziative di fede”, e così via. Il meccanismo è tecnologico finché detiene una morale pubblica ipocrita e gravosa. Così, mentre la sovranità classica è riassunta dall’espressione “prendere la vita o lasciar vivere”, il moderno Stato biopolitico ha la sua propria formula, ossia il potere quasi divino “di far vivere e di lasciar morire”.2424Ibid., p. 240.
Il passaggio dal classico al moderno deve essere ben chiaro: dal prendere la vita a far vivere e da lasciar vivere a lasciare morire.
Inoltre, in epoca moderna, far vivere e lasciar morire diventano correlati logici; vanno di pari passo, in maniera direttamente proporzionale. La vita, come impariamo, deve essere prodotta e costantemente conservata. La vita deve essere riconosciuta, la morte disconosciuta. La vita deve essere fatta; la morte non è né fatta né disfatta, semplicemente capita, per così dire. È quindi solo in epoca moderna – scrive Foucault – che si inizia a parlare di vita in maniera appropriata: siamo obbligati a parlarne, mentre manteniamo il silenzio a proposito della morte. Nelle parole di Foucault «ora la morte diventa […] il momento in cui l’individuo scappa da ogni potere, fa affidamento su se stesso e si ritira, per così dire, nella sua vita privata. Il potere non riconosce più la morte. Il potere ignora letteralmente la morte».2525Ibid., p. 248.
Negli Stati Uniti, per esempio, la morte del condannato che si trova nel braccio della morte è costruita politicamente come invisibile, mentre la “vita” della vita, la vita “innocente”, ottiene un’angosciante e costante ipervisibilità attraverso la legislazione statale (per esempio, l’abolizione dell’aborto con nascita parziale del 2003 e la legge per la protezione delle vittime non nate del 2004), attraverso l’insegnamento religioso di tipo fondamentalista, i mezzi di comunicazione di massa ufficiali e simili. All’interno di questo piano, alcune vite ottengono valore politico, mentre altre sono rimosse e depoliticizzate. Un esempio degno di nota è la vita di Terri Schiavo, che è stata politicizzata dalla promiscuità tra legislazione statale, fondamentalismo e saturazione mediatica. Come dimenticare la farsa di George W. Bush, il quasi santificato capo di Stato, che – prodigandosi per “salvare” la vita di Terri Schiavo – ha affermato: «È sempre saggio sbagliare a favore della vita»,2626G. W. Bush, President Participates in Social Security Conversation in America, The White House, Office of the Press Secretary, March 21, 2005, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/03/20050321-7.html
mentre in veste di governatore del Texas era famoso per firmare gli ordini di esecuzione e per rifiutarsi di concedere anche la minima amnistia a chiunque si trovasse nel braccio della morte. Ipocrisie simili sono di per sé difese in nome della vita. Secondo questa logica, una persona può essere un fervente sostenitore della vita e ciononostante può credere altrettanto fedelmente alla pena capitale: la morte del prigioniero è qui razionalizzata, innanzitutto perché previene il rischio di compromettere la vita e salva le vite dei vivi. È come se il prigioniero avesse già revocato il suo diritto alla vita e, in questo modo, uccidendolo non facciamo altro che lasciarlo morire – e una volta per sempre, a quel punto. Il prigioniero fa affidamento su di sé, come direbbe Foucault, e la sua morte pubblica e politica viene considerata come privata e apolitica, una necessità ignorata al massimo. La sua vita è una vita così evidentemente indegna di vivere che la morte non è mai una morte in quanto tale:2727Cf. G. Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel Heller-Roazen, Stanford University Press, Stanford 1998.
costui è l’homo sacer.
Così la “vita” è spazzata via in un discorso, prodotta in e per mezzo di un discorso, attraverso un sapere-potere discorsivo, e legittimata dallo Stato sovrano. Da questo punto di vista non si può dire che i vivi “esistano” de facto, per quanto paradossale possa sembrare, ma devono essere fatti vivere; soggetti le cui vite sono perennemente fabbricate e il cui fatto stesso di vivere e la cui salvezza sono indicizzate dalla regolamentazione, dal controllo, dalla normativizzazione e l’amministrazione statale. A causa dello sviluppo delle tecnologie mediche e governative, ora la vita dell’individuo conta innanzitutto come membro biologico della popolazione di uno Stato, come un’entità biopolitica in una moltitudine di altre o – come riassunto da Foucault – in quanto «uomo-come-specie».2828Ibid., pp. 246-247.
L’“individuo”, infatti, è destituito e viene “regolamentato” da «una tecnologia in cui i corpi sono sostituiti da comuni processi biologici».2929Ibid., pp. 249
Qui, infine, l’Altro è “autorizzato” a morire in modo da promuovere la sacra salute e il benessere della popolazione – “noi contro loro”, ossia quelli la cui morte è solo uno sfortunato effetto collaterale, presto dimenticato, disconosciuto: «La morte della razza cattiva, della razza inferiore (il degenere o l’anormale) è qualcosa che renderà la vita complessivamente più solida: più solida e più pura».3030Ibid., p. 255.
Nell’apostrofe di Foucault sentiamo la funesta eco dei programmi eugenetici, iniziati con Francis Galton in Gran Bretagna alla fine del diciannovesimo secolo e adottati all’inizio del ventesimo secolo dai nazisti, così come anche in gran parte di Europa, America e Canada. Possiamo iniziare a capire come – secondo questa moderna logica biopolitica – la “vita” in sé può diventare l’apologia estrema per la Rassenhygiene, i programmi di sterilizzazione obbligatoria, l’“eutanasia” o l’omicidio di Stato, e perfino il genocidio. E ciononostante sosteniamo a voce alta che non abbiamo “ucciso” nessuno in realtà, che la loro morte non è avvenuta per mano mia, che secondo la mia idea di responsabilità, basata sulla mia ragione sovrana e sulla mia autonomia, la loro morte è semplicemente capitata, un effetto collaterale, forse. Così io, come singolo individuo, non sono responsabile.
 Terri Schiavo fotografata insieme a sua madre, 2001.
Terri Schiavo fotografata insieme a sua madre, 2001.
Ma è necessario mettere in dubbio questa logica e portare alla luce le condizioni della nostra razionalità sovrana, della nostra egemonia. Dobbiamo porci domande difficili che riguardano il terrorismo e la responsabilità, come le seguenti, poste da Derrida: «Il terrorismo deve agire solo per mezzo della morte? Non si può terrorizzare senza uccidere? E uccidere significa necessariamente mettere a morte? Non è anche “lasciare morire”? Anche “lasciare morire”, “non voler sapere che si stanno facendo morire altri” – centinaia di milioni di esseri umani, di fame, di AIDS, di mancanza di cure mediche e così via – non può essere anche questo una parte di una strategia terroristica “più o meno” consapevole e deliberata?».3131Derrida, Autoimmunity, p. 108.
Qui Derrida mette in crisi la nostra visione biopolitica che solo i “terroristi” sottraggono le vite degli altri, direttamente o indirettamente. Derrida mette in crisi la compiaciuta posizione della sovranità occidentale, invitandoci a ripensare quello che noi normalmente classifichiamo come terrorismo e, allo stesso tempo, fa appello a ognuno di noi per immaginare le forme di responsabilità che abbiamo all’interno dell’attuale geopolitica. Ci viene chiesto di valutare la forza delle nostre intenzioni e se possiamo – o dovremmo – essere ritenuti responsabili per quello che deliberatamente non abbiamo – o non possiamo avere – intenzione di fare. Difficilmente riusciamo a concepire l’idea che il nostro semplice “lasciar morire qualcuno” sia equivalente al terrorismo, per quanto l’argomentazione di Derrida sia che siamo eticamente obbligati a pensare in questi termini – o a trovare i termini all’interno dei quali un simile discorso può trovare posto.
Eccoci arrivati a una critica appassionata del moderno umanesimo liberale, incluso il tipo di sovranità razionale a cui si accompagna. Secondo le parole di Mbembe,3232Mbembe, Brief Response, p. 3.
si tratta di «critica dell’eurocentrismo: una sorta di soggetto individuale che – pur cercando di passare per l’universale tout court – finisce sempre per legittimare la violenza della sua irrazionalità in nome della ragione». Ma una simile critica non ci autorizza ad abbracciare incondizionatamente un fluttuante tipo di relativismo postmoderno in quanto soluzione. Non credo che dovremmo promuovere una celebrazione vuota e sostanzialmente impraticabile della differenza, in cui non si può mai dire che cosa è giusto e cosa è ovviamente sbagliato (per quanto questa sia una caricatura approssimativa delle posizioni postmoderne). Semplicemente sostengo che il nostro attuale discorso sia destinato al fallimento, che dobbiamo provare a lavorare insieme per inventarne di nuovi, per trovare nuove modalità di comprensione e di comunicazione, nuovi modi di vedere. La sfida è di farsi strada tra il relativismo postmoderno e il moderno liberalismo. Da una parte, il relativismo detiene quei valori etici, sociali e legali che cambiano a seconda del luogo e dell’epoca, e non dovremmo imporre su tutti i nostri propri valori idiosincratici. D’altra parte,3333In particolare, emerge qui un paradosso problematico, radicato in profondità nel liberalismo stesso. Da una parte, tutti noi desideriamo essere considerati uguali, con uguali diritti per tutti (e uguali responsabilità, anche se questo, forse, viene ricordato troppo raramente). D’altra parte, tuttavia, esigiamo di essere riconosciuti nella nostra unicità e differenza, perché capiamo che verrebbe meno la nostra dignità se, come direbbe Kant, la nostra “uguaglianza” implicasse che ognuno di noi sia intercambiabile con un altro. In che modo, quindi, compensiamo l’uguaglianza con l’insostituibilità, due desideri presumibilmente in concorrenza tra loro? Se ci richiamiamo a un approccio basato sui diritti, il dilemma sussiste perché il sostrato dei diritti in questione è allo stesso tempo la base della nostra identicità e differenza; cioè il dilemma sussiste se persistiamo a concepire i diritti come proprietà o predicati della persona o del soggetto “sostanzialmente” umani. La maggior parte della filosofia analitica moderna continua a insistere con questa tendenza noiosa, incapace di spezzare l’incantesimo del suo proprio discorso.
Con il neoliberalismo, il paradosso del liberalismo persiste in una modalità particolarmente insidiosa e globalizzante. In questo caso siamo presumibilmente liberi e uguali, secondo le condizioni del “libero” mercato; infatti, alcuni neoliberali affermeranno che è grazie all’imparzialità indipendente delle condizioni del mercato che ognuno può trovare in esse un mezzo d’espressione della sua unicità. Ma in questo modo il mercato diventa allo stesso tempo mezzo e fine. E il mito crudele è che vi sia un’eguale accessibilità per tutti, che le condizioni del mercato siano indipendenti e imparziali. Il neoliberalismo deve assolutamente disconoscere le ineguaglianze infrastrutturali – spesso criminali – da cui dipende e che perpetua. Inoltre, deve anche negare le accuse che qualsiasi espressione di unicità possa, all’interno delle sue condizioni, risultare sostanzialmente vuota. Alcuni hanno sostenuto che un Islam fondamentalista e sempre più politicizzato fosse solo una risposta a queste ipocrisie del neoliberalismo (per esempio, si veda Boal et al., Afflicted Powers).
il liberalismo sostiene che ci siano dei valori umani universali, che noi possiamo conoscere e in base a cui dobbiamo agire. Ecco che ci troviamo di fronte a un bivio: sembra che la scelta debba avvenire tra un relativismo disordinatamente morale e culturale, che significherebbe che non possiamo decidere niente, o un liberalismo i cui stessi universali costituiranno sempre una minaccia di violenza totalitarista. Per quanto abbia esageratamente semplificato queste posizioni, sembra che per molte persone oggigiorno possa essere sostenibile uno di questi due modelli politici.
Se ci sentiamo obbligati a scegliere tra la sovranità razionale del moderno liberalismo, da una parte, e il relativismo morale e culturale postmoderno dall’altra, è perché manchiamo di immaginazione politica, la nostra attività di pensare è monocromatica. In che modo possiamo iniziare a immaginare nuove forme di soggettività politica, nuove forme di organizzazione politica – forse persino un soggetto post-sovrano? Vorrei complicare ancora un po’ le cose e far lavorare la nostra immaginazione: mi chiedo se la morte del terrorista suicida sia davvero un suicidio o se non debba, piuttosto, essere considerata come un sacrificio o come una qualche forma di vita emergente. Mi rivolgo ora all’ambivalente morte del terrorista suicida perché lui, o lei, stimoli la nostra immaginazione, ma anche perché è qui che possiamo iniziare a immaginare le cose in maniera diversa.
Traduzione di Marta Somazzi
More on Digital Library & Magazine
Digital Library
La tanatopolitica e il suicidio per mano della società
"Il tempo è finalmente scaduto... Non sono una brava persona, ho fatto cose cattive. Ho ucciso, e ora è tempo che mi uccida": su guerra e pandemia per disaffermare la biopolitica.

Digital Library
A forma di drone: parola e immagine alla fine dell’impero
La società “dronizzata” statunitense e la sua rappresentazione nell’arte contemporanea e in letteratura: dalle opere di Wafaa Bilal e Trevor Paglen ai bestseller di Mike Maden.

Magazine , LINGUAGGI - Part I
Pratiche onlife di incorporazione
Censura e iconoclastia nell’epoca del capitalismo della sorveglianza.

Magazine , LOCUS - Part I
Spazio fluido e coscienza dispersa
La casa come architettura di frontiera tra mutazione fisica e sociale.

More on Editions & Projects
Editions
Visitors
Forme di alterizzazione degli individui: quando l'othering si traduce in marginalizzazione ed esclusione sociale.

Editions
Revolution as Evolution
Le utopie del 1968 e loro effetti sulla contemporaneità, la critica d'arte militante e la sperimentazione dei linguaggi artistici.
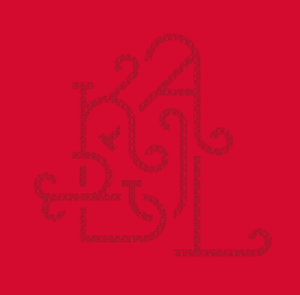
Projects
Sconfiggere il populismo sovranista con il linguaggio esoterico dell’arte contemporanea e la collaborazione dei musei
Quali sono i diversi approcci adottati da curatori e direttori di musei per condurre un workshop nella propria istituzione? Una riflessione scaturita da Q-RATED, il programma di workshop organizzato da Quadriennale di Roma.

Projects
Antropologia del mondo virtuale: Jon Rafman in conversazione con Diana Baldon
La registrazione della conversazione tra l’artista Jon Rafman e Diana Baldon, direttrice di Fondazione Modena Arti Visive, in occasione della personale realizzata da Fondazione Modena Arti Visive.

Iscriviti alla Newsletter
"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)
-
Stuart J. Murray è professore e ricercatore in Retorica ed Etica presso il Dipartimento di lingua e letteratura inglese e il Dipartimento di Scienze della salute dell'Università Carleton di Ottawa, Canada. Il suo lavoro si occupa della costituzione della soggettività umana e dei legami tra la retorica e l'etica della "vita", nei molteplici modi in cui questo termine viene utilizzato in termini biopolitici trattando i temi di salute, l'identità tramite i media digitali. Attualmente sta completando un libro relativo alla retorica della biopolitica e dell'etica dopo Foucault: “The Living From The Dead: Disaffirming Biopolitics”.
KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.
































































































































































































